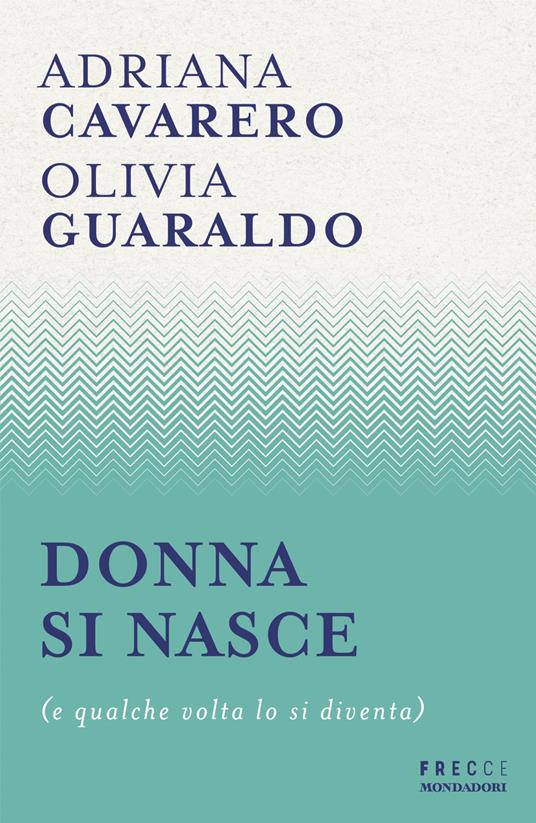L’orgoglio del materno mette in secondo piano l’opportunità che valori femminili della cura vengono accettati e sperimentati pure dai genitori di altro sesso: capacità di esprimere i sentimenti, di contattare la propria fragilità, di aver cura dell’altro. Una riflessione critica sul saggio “Donna si nasce” delle filosofe Adriana Cavarero e Olivia Guaraldi
Di Floriana Coppola
In un momento così difficile per le donne in Italia e nel mondo, in una fase che vede i femminismi non confrontarsi ma, spesso, scontrarsi, assumendo posizioni divisive, è interessante leggere e commentare il saggio delle filosofe Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo “Donna si nasce”. Fin dalle prime battute è molto chiara l’intenzione delle autrici di iper-dettagliare con precisione i confini tra i capisaldi della filosofia della differenza e i punti generali del pensiero transfemminista, intersezionalista, vicino al mondo LGBTQIA+. Spesso le autrici rivolgono un accorato appello protettivo alle lettrici, “alle care ragazze”, cercando di vaccinarle contro ogni possibile critica al femminismo della differenza. Partono dalla «funzione biologica della maternità», rivisitata come un’esperienza diretta del legame che annoda l’umano all’estrema complessità delle altre forme viventi e del loro insieme in un unico mondo, considerandolo conoscenza viscerale del Tutto.
Questa affermazione viene sottolineata molte volte nei vari paragrafi e mai si parla di genitorialità condivisa dalla coppia: le donne fanno i figli e i figli sono delle donne. Capisco che questa posizione sia stata utile politicamente nella prima e nella seconda fase del femminismo, perché bisognava recuperare una soggettività mutilata, mortificata che non lasciava spazio all’ autodeterminazione delle donne in relazione alla loro libertà di vivere la maternità non come uteri al servizio del sistema patriarcale ma come donne che sceglievano la loro vita, il loro destino di madri e di soggetti pensanti. Ma adesso è ancora utile questa impostazione così unilaterale?
Nella civiltà odierna, il problema non è solo l’emancipazione delle donne dalle vecchie stereotipie patriarcali ma anche la liberazione da uno schema univoco, per create nuovi sistemi di collaborazione e di cura relazionale. Non dichiarare che i figli nati sicuramente dalle donne sono oggetto di amore e di cura da parte di entrambi i genitori, vuol dire affermare qualcosa che avviene sotto i nostri occhi, in Italia e in Europa: il welfare familiare basato sulla sicurezza del sacrificio oblativo delle donne alla cura dei figli. Gli uomini non utilizzano nemmeno i permessi di paternità che potrebbero renderli genitori a tutti gli effetti. Viene ripreso dalle filosofe il concetto di soggettività relazionale ma poi viene tradito nel sottolineare continuamente il materno come campo valoriale da difendere, mentre sarebbe politicamente corretto far intravedere alle nuove generazioni un progetto familiare basato sulla reciprocità della cura, alla quale peraltro in molti e molte sono già attenti.
Proprio questa idea della soggettività relazionale dovrebbe aprirsi alla reciprocità, obiettivo non ancora raggiunto. Questa concezione assolutamente divergente dalla famiglia tradizionale dovrebbe essere l’antidoto per quelle situazioni a rischio, dove il grado di tossicità della coppia porta al maltrattamento e alla violenza. Educare alla cura e alle differenze, senza costrizioni di genere dovrebbe essere obiettivo politico e psicopedagogico di tutte le agenzie di formazione che incontrano le ragazze e i ragazzi ogni giorno. L’orgoglio del materno mette in secondo piano anche in questo caso l’opportunità che valori femminili della cura vengono accettati e sperimentati pure dai genitori di altro sesso: capacità di esprimere i sentimenti, di contattare la propria fragilità, di aver cura dell’altro.
La teoria femminista ha mostrato un crescente interesse per il tema della vulnerabilità della comunità, che si acutizza in relazione alle persone o ai gruppi oppressi, che vivono in situazioni precarie, questione strutturalmente intersezionale, come è sempre stato il femminismo che non ha mai dimenticato cosa vuol dire nascere donna, povera e afrodiscendente. Nessun uomo si può permettere di dire «l’utero è mio», e di affermare che il corpo della donna è di sua proprietà ma oggi nessun uomo può arretrare nella considerazione che i figli hanno bisogno di un ambiente di cura dove la tenerezza, il rispetto, l’amore sono ingredienti di entrambi i genitori e che diventano fonte di gesti importanti per una corretta educazione alla democrazia, alla cooperazione e al dialogo.
La donna è uguale all’uomo nei diritti ma non serve che si assimili ai modelli plasmati sul mondo maschile e patriarcale. Bisogna essere capaci di inventare un altro mondo. Infatti l’assimilazione non funziona. Prevede che la donna invada passivamente un mondo essenzialmente maschile, si comporti come un uomo, mediante una sorta di esercizio mimetico. Ma gli uomini si comportano come le donne tra le mura domestiche? Si tengono ancora troppo lontani dall’universo familiare di cura e di responsabilità nella casa. Nei gesti effettivi, sono ospiti a casa loro. Ben venga allora la famiglia queer, la famiglia arcobaleno, le famiglie monoparentali, di cui parlava Michela Murgia, dove il senso di responsabilità genitoriale viene condiviso fino in fondo.
Cavarero dichiara che nel lavoro esterno si finge che la differenza sessuale non ci sia; nell’ambito domestico la differenza sessuale rimane invece quella che è. La visione tradizionale relativa all’ambito domestico rimane quindi sostanzialmente intoccata. E infatti questa drammatica contraddizione come può essere superata in modo evolutivo? Proprio amplificando l’importanza di un lavoro che essendo gratuito e relazionale non venga mortificato, mentre andrebbe valorizzato per far capire a tutt* che l’ambito domestico e affettivo, lontano dalle logiche mercantili, ha pari dignità e importanza del campo lavorativo. Oggi, dopo l’elaborazione del pensiero filosofico e psicoanalitico, l’idea di persona è molto più complessa del vecchio significato latino di “maschera”, perché indica un soggetto di qualsiasi orientamento sessuale, nella sua unicità, caratterizzato da autocoscienza, dignità, libertà e responsabilità, capace di autodeterminazione e di integrare le proprie esperienze e l’ambiente circostante per formare la propria identità. Perché le nostre autrici hanno tanta paura di dire che una famiglia che funzioni si basa soprattutto su un nucleo vitale di persone capaci di collaborare a prescindere dal loro genere? La differenza di genere va utilizzata per capire le proprie specificità ma non serve per creare barriere difensive e obsolete tra coloro che hanno un progetto comune di sostegno reciproco.
Luce Irigaray dice che, per essere veramente libere e non solo emancipate, le donne devono innanzitutto sfidare l’ordine simbolico esistente e cercare di sviluppare nuovi modi di pensare e di comunicare che riflettano una prospettiva femminile autentica, non una prospettiva modellata su un sesso maschile assurto a norma. Così anche Carla Lonzi, critica d’arte, femminista e scrittrice, afferma che l’obiettivo della «rivolta femminile» non è il raggiungimento dell’uguaglianza formale fra uomini e donne, bensì l’affermazione di un ribaltamento radicale di prospettiva. Siamo capaci di spingerci oltre una posizione difensiva e creare un nuovo sistema di relazione? Serve rafforzare le barriere tra le donne, le più giovani, le lesbiche, le persone trans? E’ utile in questo momento non trovare punti di convergenza tra i vecchi e i nuovi femminismi? Abbiamo il coraggio di individuare un solo nemico comune: l’ordine simbolico del sistema patriarcale, mortifero e basato sulla sopraffazione e sulla persecuzione delle divisioni? Siamo donne capaci di esplorare l’imprevisto, il nostro essere imprevedibili, disobbedienti, creative, ribelli?
Lonzi arretra quando si rende conto di venire imprigionata da uno schema, da uno stereotipo, rinuncia a essere una critica dell’arte per questo, rinuncia a farsi considerare una teorica del femminismo per lo stesso motivo. Vuole sentirsi libera di crescere e di esplorare il mondo e se stessa senza confini, senza ideologismi, correndo il rischio di affrontare lo smarrimento e il vuoto – la tabula rasa necessaria a pensarsi al di fuori delle cornici patriarcali – solo perché sapeva di non essere sola a farlo: «è un rischio in cui mi sono accertata di essere capace di vivere ora che lo so condiviso: il femminismo mi ha dato questo. Tale rischio è il mio senso della femminilità». Aprire la parola «donna» a significati imprevisti, estranei ai ruoli e ai valori del patriarcato, è la sfida del femminismo. Per la vera liberazione è necessario un nuovo orizzonte simbolico e culturale.
Potrei dire che dopo il femminismo dei diritti e il femminismo della differenza, ora è il momento del femminismo della liberazione e bisogna essere capaci di intravedere questo orizzonte, rimanendo unite e vigili contro chi ci vuole divise e in conflitto. Non è la transessualità il nostro nemico ma il sistema cripto-patriarcale, che continua a dettare le sue regole violente. Perché includere minoranze da sempre oppresse fa tanta paura? Cosa perdiamo in questa guerra tra donne?
La filosofa statunitense Judith Butler sottolinea che la sessualità è un «dispositivo di controllo», un insieme di norme, regolazioni, proibizioni e produzioni discorsive attraverso le quali il potere e il sapere patriarcali esercitano il loro controllo sui corpi, nelle norme e nelle modalità che regolano il genere, ma anche in quelle che sottendono all’individuazione biologica primaria del sex – ovvero la differenza fra maschio e femmina. Si tratta di un dispositivo di potere finalizzato al controllo dei corpi, all’affermazione indiscussa dell’eteronormatività, ossia al postulato che l’eterosessualità, basata sull’individuazione primaria dei due sessi, sia la norma. La conseguenza è che tale normatività produce un’invisibilità per le persone – per esempio, lesbiche, omosessuali, intersessuali, transessuali – che non si conformano al paradigma eterosessuale. Butler contesta l’eterosessualità obbligatoria, considerandola una gabbia identitaria, imposta dalla logica patriarcale, ma riprodotta anche da un certo femminismo di matrice eterosessuale. Tale «normalità» si fonda sull’idea che il binarismo dei due sessi, maschile e femminile, sia naturale.
Cavarero contesta Butler proprio per questa critica al binarismo, che lei considera naturale e imprescindibile, un dato biologico assoluto. Eppure nella cosiddetta natura, tante sono le esperienze di ibridazione sessuale, ma nel testo non vengono riportate. Il binomio maschio/femmina è un dogma assoluto. Chissà che ne pensano i biologi che hanno osservato le 1500 specie animali che hanno un comportamento sessuale “fluido”? Mentre il femminismo della differenza insiste su questo, il movimento trans-femminista, intersezionalista insiste sulla diversità, individualmente auto-percepita, delle identità sessuali che sono molte e incontenibili, dirompenti. Ciò che unifica la molteplicità delle diverse identità assemblate sotto la sigla LGBTQIA+ è del resto il loro essere contro il binarismo e l’eterosessualità.
È necessaria un’alleanza politica fra femminismo e movimenti LGBTQIA+ nel contrastare le derive populiste, patriarcali e reazionarie che, in Europa come altrove, sembrano oggi trovare un terreno particolarmente fertile. La critica rivoluzionaria al binarismo e all’eterosessualità non fa scomparire le donne e la loro potenza riproduttiva. Questa è una preoccupazione che esagera una deriva assolutamente non ipotizzata. Bisogna tenere presente l’obiettivo a lungo termine: una società non violenta, che non opprime nessuna minoranza, che permette la realizzazione felice di ogni persona, di genere, di classe e di razza diverse, che educa al rispetto, alla tenerezza e all’amore, non alla sopraffazione, al potere e al successo personale, società capace di dialogare, oltre le diversità culturali e religiose, politiche e sessuali.
Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, Donna si nasce, Mondadori 2024
Floriana Coppola
Ultimi post di Floriana Coppola (vedi tutti)
- Madri si nasce? – 21 Ottobre 2025
- In giro per il mondo – 31 Luglio 2025
- Una critica femminista alle religioni – 17 Giugno 2025
- Ortese e il respiro del mondo – 29 Maggio 2025
- Ursula la sovversiva – 29 Novembre 2024