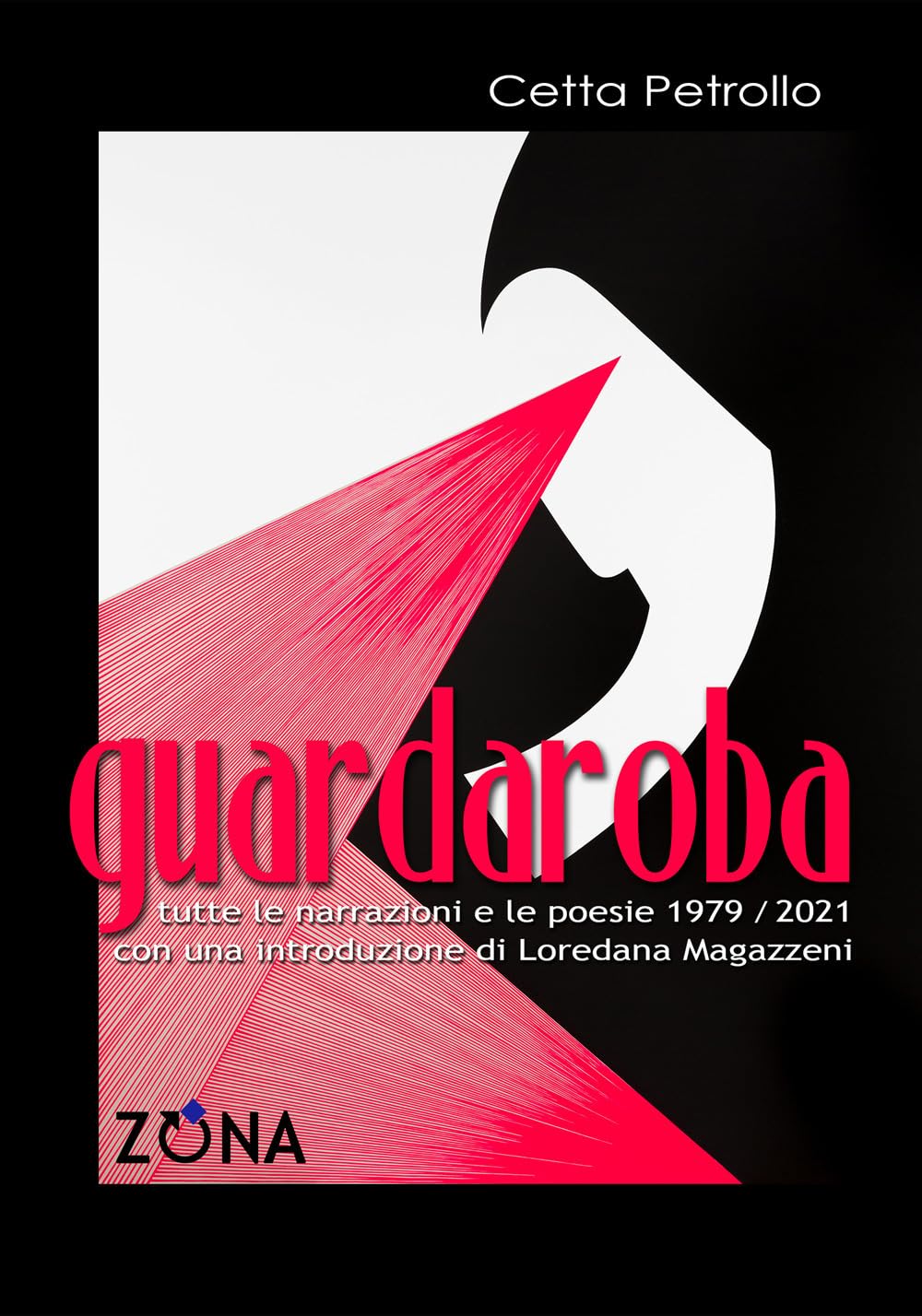«Non so dove portarvi… / ma certamente vi porterò / così come posso»… È uscito “Guardaroba. Tutte le narrazioni e le poesie 1979/2021” di Cetta Petrollo, raccolta privata e politica non organizzata per generi rigidi dove si mescolano le narrazioni e le poesie, i brani di prosa lirica, le incursioni nel teatro e nei testi brevi, in italiano e in romanesco
Di Maria Luisa Vezzali
Si legge che in natura esistono le evenienze meravigliose dei frattali, di cui l’esempio più riuscito è la felce: dalla fronda alle foglie che la formano, ai singoli elementi costitutivi della foglia, è tutta fatta di componenti autosimili, che riproducono cioè in scala sempre minore la medesima figura. Tale proprietà biomorfa, che nella scrittura potrebbe forse anche essere definita coerenza, spicca nella nuova opera di Cetta Petrollo, all’interno della quale troviamo la raccolta di brevi prose Il salto della corda che a sua volta custodisce “La vita imperfetta”, da cui estraggo questo passo:
La mia casa è mutevole. Possiede un dentro e un fuori, un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, Offre chiassosi spettacoli, il traffico continuo delle rondini nei sottotetti, la conta dei bambini nello slargo. Quando sono in casa e appendo qualche foto […] mi sembra per un momento di essermi imperfettamente trovata, di essere io, forse, non la bambina che, con un vestito imposto, guarda fra gli adulti, non la mamma che fa le foto ma nella foto non c’è, non la moglie che ha seguito e accompagnato scelte e gusti […] ma un’altra cosa, difficile da descrivere e certo imperfetta, difficile da catturare, ma che esiste con tranquilla euforia.
Tale «casa mutevole» è, per me, l’immagine più esatta dell’intero libro: un luogo composito, stratificato, che contiene molte stanze, alcune più luminose, altre intime e in penombra, e in cui ogni porta aperta rivela un passaggio verso un’altra epoca, un altro tono, un altro genere. Come in un frattale, ogni parte riflette il tutto: un racconto breve può contenere la stessa tensione poetica di una lirica, una pagina diaristica può avere la densità di un manifesto politico, una poesia può diventare il centro di gravità di una sezione narrativa.
Il libro, già, anzi il librone. Si tratta, infatti, di un’imponente auto-antologia dal titolo – antiretorico/minimizzante e ambiguo – di Guardaroba. Tutte le narrazioni e le poesie 1979/2021 (a cura di Elisabetta Destasio Vettori, Editrice Zona 2024, pp. 674, 35 euro). Antiretorico/minimizzante, perché la parola “guardaroba”, nel senso dal sapore un po’ agé di un mobile dove riporre indumenti e biancheria, non è certo altisonante: suona metà frivola e metà casalinga, e non pare avere tanto di poetico, per quanto in una bella poesia di Wislawa Szymborska leggiamo «Sono quella che sono. / Un caso inconcepibile / come ogni caso / […] / Nel guardaroba della natura / c’è un mucchio di costumi […] / Anch’io non ho scelto, / ma non mi lamento. / Potevo essere qualcuno / molto meno a parte […] / qualcuno molto meno fortunato […]» che mi pare addirsi particolarmente alla personalità di Petrollo. Ambiguo, perché il guardaroba non è solo un ambiente privato, in cui magari si nascondono i propri scheletri, ma anche quello molto pubblico e fastoso del teatro, e insomma… per chi il femminismo e la cultura degli anni ’70 li ha masticati e digeriti come la nostra autrice il fatto che pubblico e privato finiscano per sovrapporsi e coincidere non è esattamente qualcosa di alieno.
Ma anche perché “guardaroba” nel suo senso più arcaico indica colei che le robe le “guarda”, ovvero la custode delle vesti o vestale, come dice correttamente Loredana Magazzeni nella prefazione del volume. Vestale di parole, di ricordi personali e collettivi, di storie, di vita e di vite. Com’è stata sempre nella sua lunga parabola Cetta Petrollo, che concepisce la scrittura come dialogo, praticando una poesia prosastica e una prosa poetica capaci di accogliere gli altri in una dimensione estesa collettiva attraverso l’importanza data all’esperienza. Per l’autrice, d’altronde, scrivere significa far assurgere a dignità ogni scampolo di esistenza in modo che possa esprimere anche altro, come lei stessa ha dichiarato («la cultura non può che essere generosa») e praticato, grazie alle importanti biblioteche che ha diretto aprendo sempre le sale al pubblico. Una scommessa sull’unica, umana, forma di immortalità che abbiamo, ovvero quella di sopravvivere attraverso la permanenza affidata alla carta e all’impegno personale.
Guardaroba è quindi, come promette il titolo, un armadio vasto dove, più che abiti, troviamo frammenti di epoche, di relazioni, di battaglie e di ricordi. Non è una silloge organizzata per generi rigidi: le narrazioni e le poesie, i brani di prosa lirica, le incursioni nel teatro e nei testi brevi, in italiano e in romanesco, si dispongono come capi di stoffe, colori e tagli diversi, che però, messi insieme, restituiscono una figura a tutto tondo: Cetta Petrollo. Una varietà che non è dispersione, ma resistenza a un’idea monolitica di identità e di scrittura. Come nei frattali, dove le differenze di scala non cancellano la forma, anzi la confermano.
Anche l’immagine del «dentro» e «fuori», che nel passo citato è riferita alla casa, si presta a descrivere la scrittura di Petrollo: c’è un dentro intimo, fatto di memorie, di relazioni familiari, di dettagli domestici; e c’è un fuori, che è l’impegno politico, la coscienza storica, il corpo sociale in movimento. Questi due poli non restano mai separati: il fuori entra costantemente nel dentro, il privato è attraversato da voci e rumori collettivi, il politico si declina in gesti quotidiani. È qui che la curatela di Elisabetta Destasio Vettori si rivela preziosa: il lavoro di assemblaggio non appiattisce le differenze, ma evidenzia come, nel corso di oltre quarant’anni, questa dialettica sia rimasta viva e produttiva.
Significativo in quella citazione è, infine, anche il riferimento alla «moglie» che non ha soltanto seguito e accompagnato scelte altrui. Molti, infatti, conoscono Cetta Petrollo come compagna di vita di Elio Pagliarani, ma questo volume la riporta con forza al centro come autrice autonoma, dalla voce distintiva. Pur non rinnegando il legame affettivo e intellettuale con Pagliarani, Guardaroba dimostra che la sua scrittura non è mai stata ancillare, ma ha dialogato, a volte in armonia, a volte in frizione, con le poetiche del suo tempo. C’è una chiarezza d’intenti che la porta a esplorare la realtà con un linguaggio fluido, capace di passare dal lirismo più delicato alla prosa ironica e dissacrante, senza perdere la sua impronta.
Tra le molte tappe di questo viaggio, Il salto della corda (Manni 2006) – che è forse la raccolta che ho più amato – si presenta come un laboratorio di condensazione poetica, dove ogni testo è una piccola architettura autosufficiente e contemporaneamente si presenta come la tessera necessaria di un tutto in cui Petrollo gioca con il ritmo in ogni sua declinazione. Quello del tempo naturale, con il susseguirsi delle stagioni, e quello della parola, che scoppietta energica e vitale. Si pensi all’incipit:
Calo con cautela il panierino (cala, cala) memore di altre discese nel cortile della nonna (cala, cala diceva il postino, cala, cala l’uomo del latte, cala il giornalaio, cala le parenti zitelle di ritorno dalla spesa, cala il fagottino della merceria, il velo da messa scordato, il bicchiere col bicarbonato, la busta di liscivia).
All’epoca che le fanciulle (Editrice Zona 2016) è, invece, la raccolta che conosco meglio, per averla presentata al momento della sua uscita. Qui ci si trova davanti a un prosimetro che crea in chi legge un’impressione ipnotica, quasi di stordimento. Fa l’effetto di una macchina del tempo, o meglio una sorta di ascensore temporale, che trasporta autonomamente su e giù per le «epoche», appunto. Inizialmente proietta in un passato remoto, per quell’inizio che già “agisce” sul tempo e per quel soggetto delicato e anacronistico (le «fanciulle»); non solo remoto ma anche favoloso per la presenza arcana di un «gran mago» e per l’accumulo di giardini, castelli, regni, tele e tessitura. E anche la successione, o meglio la processione che si attua pagina dopo pagina, testo dopo testo, sembra confermare questa impressione, come se ci si trovasse di fronte a un trionfo allegorico medievale o allo spettacolo di un seguito di vergini in candidi pepli durante un rito sacrificale mediterraneo. Ma poi qualcosa non quadra. Intanto le fanciulle hanno «sessant’anni», e qui avviene il primo cortocircuito temporale, la proiezione in un tempo onirico dove le leggi sono stravolte. Inoltre anche la sintassi non torna.
È irrimediabilmente irriverente, sussulta, si lascia attraversare dal respiro (o forse ancora meglio, dal fiato), dà l’impressione del flusso di un parlato incontenibile («a dirsi che esse dovevano, potevano, rischiare, ancora e fino alla fine, continuando a narrare, ancora e fino alla fine, continuando ad amare»), fa volentieri a meno di quel «materiale statico» che è la punteggiatura. Ed ecco allora che per mezzo di questa scrittura – che si potrebbe definire “innamorata”, se la formula non alludesse a tutt’altro modello e a tutt’altra genealogia, e che allora definirò pulsionale, desiderante, di fortissima evocazione – comprendiamo che il messaggio è assolutamente contemporaneo: si sta parlando di noi oggi, della nostra natura pervicacemente comunicante anche attraverso un «sms sperduto» o tra le righe di una chat metamorfica che si divincola «come uno scoiattolo veloce», perché il passato non è inesorabilmente perduto e la carta da giocare è quella dell’azzardo della comunicazione, del provare a condividere ancora qualcosa di animato, un sovrappiù di senso, cui non si può rinunciare appiattendosi sulla vulgata propinata dai mezzi banalizzanti delle nuove tecnologie.
Il messaggio fondamentale che All’epoca delle fanciulle riesce a far passare è una di quelle cose semplici che però non si pensano mai. Ovvero che la letteratura è piena di romanzi di formazione, fin dal Wilhelm Meister di Goethe, ma in fondo fin dalla Telemachia. Che la scrittura si è impegnata assai a mostrare vie ai giovani per crescere e diventare adulti, ribadendo l’antica legge del pathei mathos, della conoscenza attraverso il dolore. Ma che non sono poi altrettanto numerose le opere che insegnano a passare dall’età adulta all’età successiva, soprattutto quando si tratta di donne. Questa raccolta è anche una favola su questo tema. Un tema per il quale non serve un romanzo. Anzi serve forse un non-romanzo. Un non-romanzo di liberazione: dalla forma della scrittura, dalla schiavitù del genere e per traslato anche dalla schiavitù della giovinezza e delle certezze. Per usare un’espressione che per Petrollo è familiare, un non-romanzo attraverso il quale «si impara o non si impara a crescere». E di questo tutte noi donne, vecchie fanciulle, possiamo esserle davvero grate.
È impossibile passare in rassegna ogni raccolta, dato che l’antologia copre un arco temporale dal 1979 a oggi, un arco durante il quale il mondo, la politica, i rapporti di genere, la stessa idea di letteratura hanno subìto mutamenti radicali. E di certo leggendo Guardaroba si avverte questa lunga durata – gli anni più militanti, gli slanci utopici, la disillusione post-ideologica, e poi una fase più riflessiva, dove la memoria diventa materia di resistenza –, anche se la scrittura di Petrollo non segue un’evoluzione lineare, bensì una curva più imprevedibile, spiraliforme, e temi, immagini, ritmi ritornano trasformati, richiamandosi da un testo all’altro. Però è significativo che il volume si chiuda con la poesia “Cercano ricovero i dimenticati” (pubblicata su “La Repubblica” di Milano il 3/10/2022), la quale parte con un elenco («i troppo anziani i superati / dagli anni che furono / le cose non dette le trascuranze / della fretta i seppelliti dalle ceneri / del conformismo») che offre già un’idea del tono: il testo non innalza solo un lamento per tutti gli emarginati, ma presenta un’offerta di «ricovero», un luogo protetto per chi è stato escluso dalla storia. E subito compare il corpo, associato a immagini geologiche («le strettoie della carne» insieme «agli spuntoni dei ricordi / frane laviche erose»), perché la fragilità fisica convive con la fragilità della terra: la «carne che cede» è fissata nella sua debolezza, ma anche nel suo «profumo»; è uno strumento di esperienza, ma soprattutto di cura.
Questa è la voce più riconoscibile di Petrollo: lontana dal melodramma, lucida, consapevole del destino di coabitazione tra impossibilità e volontà caparbia («Non so dove portarvi… / ma certamente vi porterò / così come posso»). Una voce che si autodefinisce con la sicurezza del proprio radicamento etico: «ampia come l’abbraccio / che comprende / aperta come il gesto / che traduce».
Cetta Petrollo, Guardaroba. Tutte le narrazioni e le poesie 1979/2021, a cura di Elisabetta Destasio Vettori, introduzione di Loredana Magazzeni, Editrice Zona, 2024, pp. 674
Ultimi post di Maria Luisa Vezzali (vedi tutti)
- Vestale di vita e di vite – 16 Novembre 2025