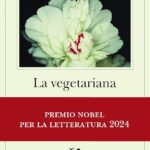 Il circolo di lettura della Sil legge La vegetariana della premio Nobel sudcoreana Han Kang. Un romanzo in tre parti, dove i rapporti di forza tra uomo e donna, tra padri e figl* e tra umani e animali sono violenti. L’intreccio, tra realismo e fantastico, ha creato straniamento e persino disagio in alcune, anche se molte sono le emozioni positive
Il circolo di lettura della Sil legge La vegetariana della premio Nobel sudcoreana Han Kang. Un romanzo in tre parti, dove i rapporti di forza tra uomo e donna, tra padri e figl* e tra umani e animali sono violenti. L’intreccio, tra realismo e fantastico, ha creato straniamento e persino disagio in alcune, anche se molte sono le emozioni positive
Di Gianna Cannì
La vegetariana di Han Kang è un romanzo ipnotico, doloroso come uno specchio distorto o ragnato che ci presenta una cultura estranea e lontana, ma che sa già di futuro imminente. Antonella Ippolito, nell’incontro delle Letturate (di cui provo qui a restituire le voci), ha infatti subito posto la questione se il romanzo non stia in un nesso forte con la società sudcoreana, per la rappresentazione così cruda dei rapporti di forza tra uomini e donne e tra padri e figli e per l’intreccio tra realismo e fantastico che pervade tutta la narrazione. Sicuramente l’effetto di straniamento e disagio che tutte abbiamo provato nella lettura – sottolineato soprattutto da Pina Mandolfo, che ha espresso una forte perplessità verso questa invenzione narrativa così distruttiva – è anche dato da questa distanza, che però è in rapporto dinamico con un tempo inquietante che già intravediamo: un universo profondamente perturbante, dove ogni cosa è familiare e insieme unheimlich (inquietante, Marzia La Barbera). È una narrazione così potente e quindi inesauribile che ogni frase potrebbe aprire un mondo interpretativo sorprendente; sono quindi costretta a ridurre la ricchezza degli scambi tra noi, proseguiti oltre l’incontro anche via mail.
La storia si articola in tre parti e si passa dalla voce narrante del marito di Yeong-hye, la protagonista, ad una voce in terza persona ma focalizzata prima sul cognato di lei e poi sulla sorella In-hye. Nella prima parte, intitolata La vegetariana, il marito racconta con sgomento, incapace di qualsiasi comprensione, la scelta della moglie (disprezzata e sposata per la sua insignificanza) di diventare vegetariana. La motivazione nasce da un’esigenza etica, ma concepita all’interno di un sogno; è il tentativo di silenziare le immagini oniriche che grondano sangue animale. In questo sangue si condensa una violenza che viene da lontano (il sogno è – anche etimologicamente – la traduzione del trauma d’aver assistito all’uccisione barbara di un cane in ossequio ad una credenza superstiziosa) e che pervade ogni pagina in maniera quasi insostenibile.
La donna si ribella alla violenza familiare ma anche sociale con l’unico potere di cui dispone, quello di scegliere come e se nutrire il proprio corpo (Rossella Caleca) ed è un rifiuto che passa dal crinale dell’autodistruzione (Licia Ugo). Questa scelta è una forma di estrema resistenza alla rapacità dei rapporti, al patriarcato e all’antropocentrismo stesso (Loredana Magazzeni) e approda infine a una metamorfosi/ibridazione della vegetariana: simile a una moderna Dafne (Rita Lopez), Yeong-hye si spoglia del corpo umano e assume sembianze vegetali. Se nel mito classico la metamorfosi è fuga dal desiderio dell’altro, qui la questione è più complessa.
Nella sezione centrale del romanzo intitolata La macchia mongolica – che ad alcune è parsa talmente brutale da potere essere assimilata alla pornografia – avviene un passaggio importante, che è anche quello che personalmente ho trovato più magnetico: il cognato, artista in crisi, sviluppa una potente ossessione per il corpo di Yeong-hye, che conserva ancora sulla pelle una verdognola macchia mongolica. C’è come un quadrato distorto del desiderio, una struttura chiastica: i due uomini sono sessualmente attratti dalla rispettiva cognata, mentre le due donne subiscono la violenza domestica esercitata dal proprio marito.
Schiavo della “visione di un fiore azzurro, con i petali che si schiudevano, nelle natiche” della cognata, il marito di In-hye convince la vegetariana a interpretare la sua fantasia dell’accoppiamento di un uomo e una donna completamente ricoperti di fiori dipinti sulla pelle. La metamorfosi vegetale di Yeong-hye, pur essendo una scelta di rifiuto della carne animale e della propria carne, inizia paradossalmente nel desiderio di un uomo che la intravede come in sogno già fatta di foglie e petali. Lei vive nei sogni propri e dell’altro, deve però ancora conquistarsi radici da albero e diventare dritta e radicata quando come donna invece non è mai riuscita a stare in piedi (Nadia Tarantini).
Nel terzo atto – Fiamme verdi – il baricentro si sposta drammaticamente e la violenza sessuale (in tutte le sue forme) cede al progressivo spogliarsi dell’umano (Elvira Federici) da parte di Yeong-hye e forse al processo inverso di umanizzazione di In-hye, che prende coscienza di essere stata nella sua docilità servizievole e responsabile in un certo senso complice della violenza subita dalla sorella: «Yeong-hye era stata l’unica vera vittima delle percosse del padre […]. Adesso, col senno di poi, In-hye capisce che il ruolo della figlia maggiore laboriosa e altruista che aveva adottato allora era stato un segno non di maturità, ma di vigliaccheria». Ma intanto la chiamata dagli alberi è ormai avvenuta e anche In-hye si aspetta di sentirli parlare, mentre una ferita nera tra le gambe pare risucchiarla e la stessa insonnia della sorella tenerla nella sua morsa: «In-hye non era riuscita a trovare un solo albero che volesse prendere la sua vita».
La figura della sorella, che sembra battere il tempo delle ultime ore di Yeong-hye e che l’accompagna nell’ultimo viaggio in ambulanza costeggiando una foresta viva e vibrante («Nella fioca luce pomeridiana le foglie bagnate di pioggia emanano un intenso luccichio, accendendo un fuoco verde») indica una possibile altra liberazione, come hanno sottolineato soprattutto Pina, Rossella e Rita, ma di nuovo “è solo un sogno” e In-hye si interroga come in sogno sulla facilità con cui ha preso la decisione di abbandonare suo figlio.
Le coordinate spazio temporali sono traballanti, la partizione classica in tre atti in realtà sposta i piani, apre altre dimensioni: si procede dallo sguardo mediocre del marito, che assiste a un cambiamento che non capisce alla sorellanza arborea, intuita dalla sorella, anche lei immersa in una sua metamorfosi più silenziosa e invisibile, passando prima attraverso il desiderio sessuale del cognato che disegna la sua mappa verde sul corpo di lei (tra l’altro la fantasia nasce da una frase casuale detta da In-hye che suppone che Yoeng-hye quella macchia l’abbia ancora, a riconferma del quadrato erotico di cui si diceva prima). Il legame tra le sorelle si rinforza e si fa vivo come sviluppo naturale e prossimità all’interno di un avvicinamento alla morte, al mettere radici sotto terra, mentre si lascia cadere l’esile filo che lega alla vita attraversando il caos.
In questo romanzo in cui tutto è metafora che rimanda ad altro, si intravede una strada nuova di auto appropriazione, che consiste – sono parole di Gisella Modica – nel cercare dentro di sé, scavando nel rimosso, nei sogni, nell’invisibile, forme di lotta al patriarcato, attraverso la metamorfosi e la ricerca di altre forme di vita non più umane, imparando dal mondo vegetale visto che l’umano è materia già morta.
Per questo morire non è così terribile. Per questo la domanda vera che il romanzo mi sollecita è se si inizia a morire o a vivere quando i sogni – quel nucleo indissolubile di trauma e desiderio – si impossessano della realtà; se il destino dell’umano è andare oltre l’umano.
Per concludere, in un universo di immedicabile violenza la sola vera comunicazione sembra essere tra la dimensione onirica e la realtà. Verso la fine, In-hye – quando sente dire dalla sorella che ormai non ha più bisogno di mangiare, che ha bisogno solo del sole – le chiede: «Veramente pensi di esserti trasformata in un albero? Come fa una pianta a parlare?». Yeong-hye le risponde: «Le parole e i pensieri presto spariranno. Manca poco. Prestissimo. Bisogna aspettare ancora un pochino, sorella»: ecco perché questo romanzo enigmatico e bellissimo continua in chi lo ha letto anche dopo che le parole sono finite.
Gianna Cannì
Ultimi post di Gianna Cannì (vedi tutti)
- Letturate 5. Perché, è così terribile morire? – 23 Maggio 2025


